La Rete caffè narrativi è alla ricerca di ambasciatori e ambasciatrici regionali per creare strutture di caffè narrativi vivaci a livello locale. Insieme ci rivolgiamo a istituzioni locali come biblioteche, associazioni di quartiere, comuni e parrocchie. Rhea spiega quali sono le qualità richieste per questo ruolo e come viene remunerato il lavoro.
Perché la Rete caffè narrativi sta cercando ambasciatori e ambasciatrici regionali?
Rhea Braunwalder: Dal momento che la nostra è un’associazione nuova vorremmo estendere l’esperienza dei caffè narrativi a un pubblico più vasto. Il nostro obiettivo è far sì che i caffè narrativi prendano piede in tutte le regioni della Svizzera. Affinché tale attività sia sostenibile nel lungo periodo, abbiamo bisogno di persone in loco che abbiano una buona rete di contatti e che mantengano vivo l’interesse. Non basta che una sede centrale organizzi caffè narrativi una tantum in ogni angolo del Paese.
Chi può presentarsi?
Cerco personalità con spirito di iniziativa disposte a realizzare un progetto di caffè narrativi o a far diventare il metodo del caffè narrativo una realtà radicata nella propria regione. La persona deve avere una buona rete di contatti, essere alla mano e comunicativa. Insieme contatteremo le parti interessate nella regione e faremo in modo che gli ambasciatori e le ambasciatrici possano organizzare autonomamente i caffè narrativi.
È necessario avere esperienza di moderazione?
Non è strettamente necessario avere esperienza nella moderazione di caffè narrativi. L’unica cosa importante è aver sperimentato personalmente il metodo nell’ambito di un caffè narrativo ed essere convinti della sua validità. Gli ambasciatori e le ambasciatrici regionali sono in contatto con i moderatori e le moderatrici della loro regione e svolgono una sorta di funzione di interfaccia tra l’associazione e i moderatori. Il segretariato è in stretto contatto con la persona e la sostiene attivamente.
Come si svolge concretamente il lavoro degli ambasciatori e delle ambasciatrici regionali?
Può variare molto a seconda della regione e delle possibilità della persona. La persona…
- funge da referente per altre persone interessate nella regione;
- mette in contatto moderatori e moderatrici nuovi ed esperti residenti nel cantone;
- affianca lo sviluppo di una rete cantonale di caffè narrativi ed è disponibile a contattare istituzioni, organizzazioni, partecipanti e pubblico;
- sostiene corsi introduttivi regionali e invita partner locali;
- una volta all’anno partecipa a un incontro con gli ambasciatori e le ambasciatrici regionali;
- avvia un progetto di caffè narrativi con altre persone del quartiere;
- può essere indicata sul sito web come persona di contatto per la regione.
Quali sono i vantaggi per le persone che si impegnano ad assumere il ruolo di ambasciatori e ambasciatrici regionali della rete?
- Possono partecipare al corso “Formazione continua 2024: pronti ad affiancare moderatori e moderatrici” a un prezzo scontato.
- Ricevono consulenza e supporto dalla rete e sono in stretto contatto con una persona del segretariato.
- Vengono remunerati con un forfait più spese.
- Partecipano gratuitamente alla tavola rotonda e all’intervisione.
- Ricevono apprezzamento e stima.


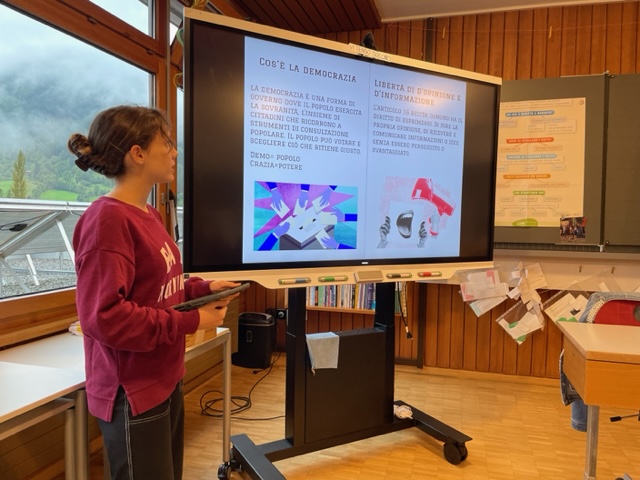
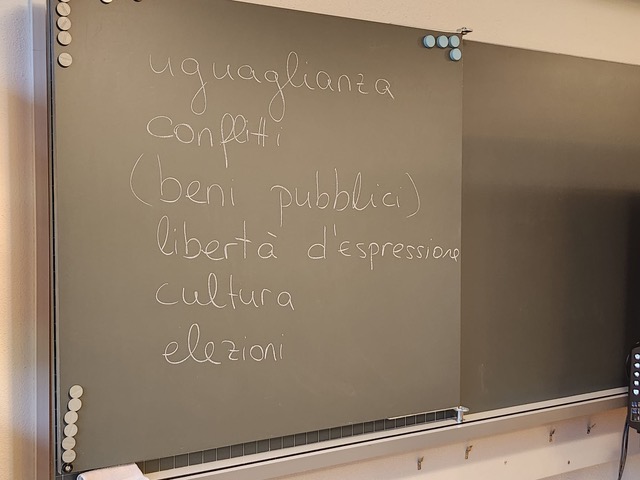
 Natalie Freitag è la coordinatrice regionale della Rete nella Svizzera tedesca. La donna, originaria della Svizzera orientale, ha moderato la conferenza e ha concluso affermando: “Vi invito a preparare con cura anche i caffè narrativi dove un solo cerchio di sedie non è più sufficiente”.
Natalie Freitag è la coordinatrice regionale della Rete nella Svizzera tedesca. La donna, originaria della Svizzera orientale, ha moderato la conferenza e ha concluso affermando: “Vi invito a preparare con cura anche i caffè narrativi dove un solo cerchio di sedie non è più sufficiente”.
 Vanessa Merminod è la coordinatrice di Pedibus Vaud. Come tale, si occupa di far conoscere il programma Pedibus in tutto il Cantone e collabora con i Comuni, le scuole, la polizia stradale, ecc. Inoltre, sensibilizza e aiuta i genitori a creare percorsi Pedibus.
Vanessa Merminod è la coordinatrice di Pedibus Vaud. Come tale, si occupa di far conoscere il programma Pedibus in tutto il Cantone e collabora con i Comuni, le scuole, la polizia stradale, ecc. Inoltre, sensibilizza e aiuta i genitori a creare percorsi Pedibus.
